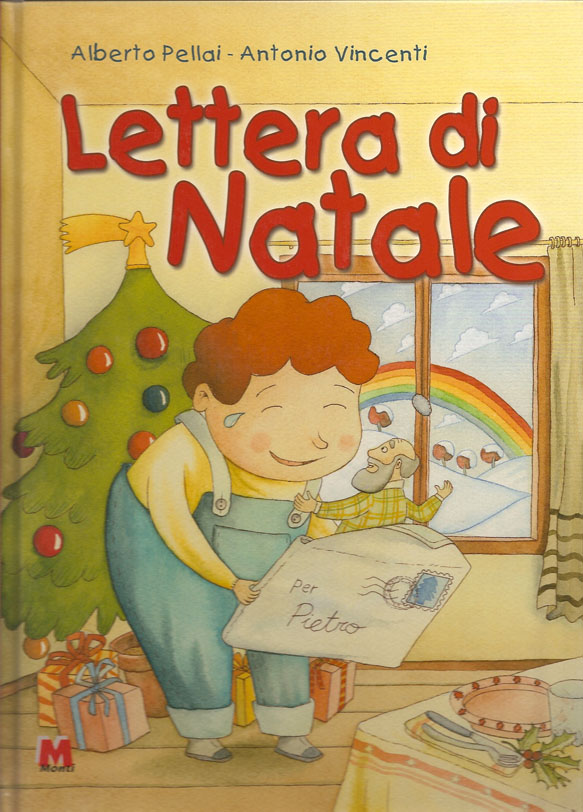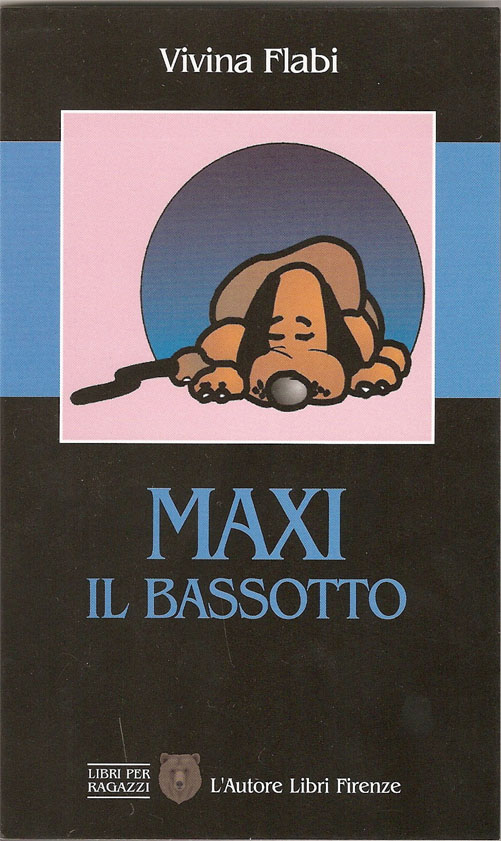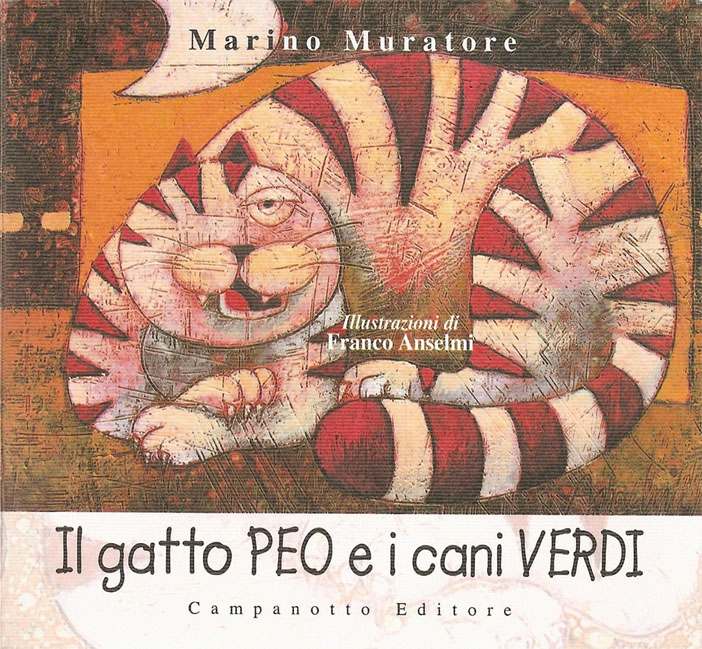SEZIONE RACCONTI
I partecipanti dovevano obbligatoriamente prendere le mosse dall’incipit di Maurizio Maggiani tratto dal romanzo – Il coraggio del pettirosso (1996): “Avevo riportato sulla spiaggia quel libro, ma mi pesava trovarmelo in casa: mi dava l’impressione di conservare indebitamente un segreto”.
1° classificata: PAOLA DIGHERO di Genova con “Macramé”
Avevo riportato dalla spiaggia quel libro, ma mi pesava trovarmelo in casa: mi dava l’impressione di conservare indebitamente un segreto.
L’avevo notato sulla bancarella di un robivecchi, nel mercatino che si svolge una volta al mese sulla passeggiata, a ridosso delle cabine a righe bianche e azzurre: “Il pizzo al tombolo. Storie di fili e di mani”. Sotto il titolo c’era la riproduzione di una vecchia cartolina color seppia: “Merlettaie a Santa Margherita Ligure. 1910”. Alcune donne, giovani e anziane, erano sedute composte, ciascuna con il proprio tombolo davanti; una bambina dell’età di cinque o sei anni, con un grembiulino bianco, faceva capolino dietro l’ultima sedia della fila, sorridendo timida con gli occhi spalancati che, pur nell’uniformità cromatica della vecchia foto, si indovinavano chiari: azzurri, o forse grigi.
Incuriosita, avevo iniziato a sfogliare le pagine. Sulla terza di copertina una breve dedica, senza firma, mi aveva portato indietro di vent’anni, a un’estate di sole e di vacanza. Immagini nitide avevano cominciato a scorrere davanti ai miei occhi, come in un film.
Il fatto è, che io sapevo a chi apparteneva quel libro. Sapevo chi l’aveva comprato, a chi lo aveva regalato, e perché.
* * *
Afa. Bonaccia.
Il mare è immobile, grigio, di una densità piatta come in un quadro a olio dipinto da una mano poco felice. Su una chiazza blu intenso, delineata dalle correnti, un piccolo cabinato, le vele tristemente ammainate, procede a motore.
Un gabbiano si alza faticosamente in volo, alla ricerca di un alito di vento che possa sorreggere la sua planata verso il largo; non lo trova, scende disegnando una lenta spirale. A un tratto incontra una leggera brezza, risale, aggiusta la rotta, allarga le ali per sfruttare l’agognato sostegno dell’aria, plana per alcuni secondi, poi inizia a scendere, vira, si rassegna a battere le ali e ricomincia da capo.
Dalla spiaggia arrivano suoni attutiti dall’afa, lo sciacquio leggero delle onde, scampoli di conversazioni pigre, il fastidioso ronzio di un motoscafo che sfreccia al largo.
Le fronde della palma mi riparano dai raggi spietati del sole ma non dal riverbero della luce gialla; inforco gli occhiali scuri e mi faccio aria con il libro. Odio la spiaggia affollata. Detesto andare alla ricerca di un po’ di spazio per stendere l’asciugamano e incastrarmi come il tassello di un gigantesco rompicapo in quel tappeto umano di pelle sudata. Così passo i pomeriggi a leggere, seduta su una panchina della passeggiata, all’ombra delle palme; aspetto che la spiaggia si svuoti, che i bagnini inizino a chiudere gli ombrelloni. Allora scendo e mi tuffo nell’acqua tiepida e nella luce rosata del tramonto, poi mi sdraio sulle pietre calde e ascolto lo schiaffo gentile dell’onda e lo scricchiolio dei sassolini che rotolano nella risacca: sciafff – scrrrrr, sciafff – scrrrrr. Il respiro del mare.
“Va ben chì, lalla?” Un giovanotto in tuta da meccanico, alla mia destra, fa accomodare su una sedia all’ombra una vecchina che sembra uscita da una favola.
“Sci, cao, va ben. Grassie.” La donna sistema un tombolo davanti a sé e rivolge uno sguardo riconoscente al ragazzo che la saluta allontanandosi. Fissa un disegno con gli spilli e si mette al lavoro. Clic clic clic, fanno i fuselli di legno. Osservo affascinata l’antica sapienza di quelle mani rugose che sembrano volare tra i fili come farfalle.
Clic clic. Un nodo. Clic cli-clic. Un altro nodo.
Da anni non vedo più ricamatrici sulla passeggiata. Il ricordo va alle belle domeniche di primavera della mia infanzia, quando era frequente imbattersi in gruppi di merlettaie che lavoravano chiacchierando, mentre sulla spiaggia i loro uomini riparavano le reti, quasi che le loro vite fossero tenute insieme da una serie infinita di nodi.
Le chiedo se posso sedermi accanto a lei per osservarla lavorare. Annuisce senza smettere di annodare, con l’aria di chi è abituato alla curiosità altrui. Negli archi e trafori della lunga striscia di merletto vedo il soffitto di un palazzo moresco, il rosone di una cattedrale gotica, la complicata semplicità di un fiocco di neve. Mi viene da chiedermi in quante case ci sia un piccolo capolavoro di pizzo costato ore d’impegno, giorni, mesi, vita.
Procede spedita, fermandosi di quando in quando per spostare lo schema; gli occhi vagano sul mare, mentre le mani esperte continuano la loro danza lieve.
“Cose scià leze?” mi chiede.
“Come? Ah, è un libro di racconti di viaggio. Vuole che gliene legga uno?”
Fa cenno di sì con la testa, sorridendo. Incomincio a leggere. Ogni tanto mi fermo per riposare, mentre il clic clic dei fuselli continua discreto.
“Bello!” esclama, alla fine del racconto, “T’è torna chì, doman?”
E’ passata dal “voscià” al tu, come se il piacere condiviso della lettura ci avesse reso amiche nonostante nessuna delle due sappia neanche il nome dell’altra.
“Sì. Le leggo un altro racconto” prometto, mentre mi alzo per dirigermi alla spiaggia. Annuisce e mi fa un cenno di saluto.
* * *
Un mese dopo siamo ancora lì, sotto la palma; ogni pomeriggio io leggo, lei annoda i suoi merletti, guardiamo il mare e la gente che passa.
C’è un gruppo di giovani del posto che si ritrova alla spiaggia sul tardi, dopo il lavoro o lo studio. Alcuni arrivano a coppie, abbracciati, e se ne vanno tenendosi per mano, con i capelli ancora umidi e gli asciugamani arrotolati sotto il braccio.
Nella compagnia c’è un ragazzo alto e magro, con il viso dolce. E’ il meno chiassoso del gruppo; di solito resta un po’ in disparte, gli occhi sempre puntati su una biondina dalla risata contagiosa.
Oggi la ragazza è arrivata un po’ prima del solito. Seduta sul muretto verso il mare, sembra aspettare qualcuno. Passa un quarto d’ora; la giovane guarda impaziente l’orologio, sbuffa e si allontana.
Poco dopo arriva il ragazzo magro, trafelato. Ha in mano un mazzolino di fiori legato con un nastro che tormenta con le mani nervose. Si guarda in giro con un’espressione disperata, poi si volta a capo chino e fa per ritornare sui suoi passi.
“Me pa che a segge andaeta in sciû.” La voce squillante della vecchina mi fa trasalire.
“Prego?” Il ragazzo si volta, stupito.
“A figgieua, diggo. A l’è andaeta verso a gexa.”
“Quale ragazza?” sussurra imbarazzato, “Io non stavo cercando nessuno.”
“Ah, no? Scûsae, me paiva de scì.” E si rimette all’opera.
Il giovane osserva per un attimo le dita nodose e la complicata trama dei fili di cotone, quindi alza gli occhi nella direzione indicata dalla donna. Mi rivolge un’occhiata incerta, fa finta di guardare l’orologio, cerca qualcosa in tasca. Improvvisamente, raddrizza la schiena e si avvia a grandi passi verso la chiesa.
Guardo la vecchina.
Clic clic. Un altro nodo.
“Côri, se no, no ti a piggi!” gli grida, senza distogliere l’attenzione dal suo merletto.
Il ragazzo non si gira, ma ha sentito. Cerca per un attimo ancora di darsi un contegno, poi rompe in una corsa affannata.
Clic clic. Un nodo. Clic cli-clic. Un altro.
Passano dieci minuti buoni, poi la donna alza lo sguardo al di sopra della montatura degli occhiali. Mi fissa con quegli occhi azzurro ceruleo, due capocchie di spillo colore del cielo in mezzo alla ragnatela delle rughe; fa un sorriso furbo e complice, attende che le sorrida a mia volta. Senza dire una parola si rimette al lavoro.
Clic clic. Un altro nodo.
* * *
“Officina” diceva l’insegna. Entrai con il libro sottobraccio. Mi venne incontro un uomo con la tuta macchiata di grasso. Nonostante qualche chilo in più e parecchi capelli in meno, riconobbi il ragazzo che accompagnava la mia vecchina sulla passeggiata.
“Sono venuta a portarle qualcosa che apparteneva a sua zia” gli dissi, porgendogli il libro. Gli spiegai che avevo fatto il giro delle officine di Santa Margherita per trovarlo, perché non conoscevo né il suo nome, né, per quanto fosse assurdo, quello di sua zia.
Mi guardò con aria interrogativa. Poi mi fece accomodare in un piccolo ufficio, dove gli raccontai tutta la storia.
“Non era mia zia” mi rivelò quando ebbi finito. “Era una vicina di casa. La chiamavo lalla perché la conoscevo da quando ero nato. Era sola al mondo. Saranno quindici anni che è morta. Lo tenga lei, il libro. Credo che sarebbe contenta.”
Passeggiai un poco sul lungomare, finché trovai la nostra palma. Mi sedetti sulla panchina chiedendomi che fine avessero fatto il suo tombolo e i suoi fuselli. Immaginai qualche lontano parente, qualche vicino distratto, intento a riempire scatoloni di oggetti che avevano un valore solo per lei. Forse in un mercatino qualcuno stava osservando svogliatamente un macinino, una radio, un pettinino d’avorio.
Sfogliai il libro.
La dedica spiccava sulla pagina bianca: “Grazie per aver annodato le nostre vite.”
Forse era giusto davvero che quel libro rimanesse a chi conosceva la storia che le pagine non raccontavano.
Alzai lo sguardo sul mare increspato. All’orizzonte il cielo era di un azzurro ceruleo che sembrava sorridere. Sentii, nella mia testa, un rumore discreto e lontano.
Clic. Un nodo. Clic clic.
2° classificata: PAOLA DE STEFANI di Biella con “Olga”
Avevo riportato dalla spiaggia quel libro, ma mi pesava trovarmelo in casa: mi dava l’impressione di conservare indebitamente un segreto.
Dovevo fare in fretta a riportarlo al suo posto prima che lei se ne accorgesse, avevo giusto il tempo per uno sguardo veloce.
Me lo ripeteva, mio padre:
-Non ti fidare delle donne, sono strane. Non sai mai cosa pensano.
Così non mi sono mai sposato. Non credo che mi sposerò mai. Finora ero riuscito a scampare al pericolo, a restarne lontano. Ma poi…
Era andata così: Ernesto, il mio amico, sosteneva che il punto era suo, mentre era evidente che la boccia più vicina era la mia. A volte lo strozzerei quell’uomo per la sua testa dura. Così ero andato a prendere il metro per dirimere la faccenda, mentre lui ridacchiava.
Ultimamente rideva sempre. Immagino fosse perché si era appena risposato, con una ragazza albanese.
Invece io ero di pessimo umore. Ero arrivato con il metro e con una tale foga che avevo messo il piede sul boccino e patapùm, per terra, caviglia rotta, e per giunta ancora adesso non so se il punto era mio.
Lina, mia sorella, aveva insistito perché prendessi una badante:
-Da solo non ce la fai, ci vuole qualcuno che ti aiuti, almeno fino a quando non ti rimetti in sesto.
-Non se ne parla!
Va bene che sono in pensione, ma non ho mica ottant’anni. Niente da fare, non aveva voluto saperne. Aveva fatto tutto lei, tramite un’agenzia. Così, una mattina, mi ero trovato sul pianerottolo una ragazza di venticinque anni, alta una spanna più di me, con capelli neri e impassibili occhi ucraini:
-Perdona… tu è professor Giovanni Bianchi?- aveva chiesto allungando una mano verso di me.
-Sì- avevo risposto stringendola con cautela.
-Io Olga Stepànovna.
Così Olga era entrata nella mia casa e nella mia vita.
Era una brava badante, mi accompagnava alla spiaggia a prendere il sole per le ossa. Io mi sedevo sulla sdraio, davanti al mare, e lei si sistemava un po’ più in là, a leggere un suo libro, sempre il solito, foderato di rosso.
Quando finiva, lo ricominciava, quasi volesse mandarlo a memoria. A volte lo chiudeva, con un dito a mo’ di segnalibro e mi indirizzava certe occhiate penetranti e indecifrabili.
In quei momenti mi tornava in mente mio padre. Non sai mai cosa pensano.
Un giorno, mentre Olga nuotava, avevo messo la mano nella sua borsa in cerca della crema solare, invece avevo fatto cadere fuori il libro. Quello si era aperto mentre volava sulla sabbia. Ora, non potevo giurarlo, ma mi era parso di vedere una foto alla quale avevo stentato a dare un senso: una donna nuda che massaggiava con le mani il petto di un uomo. Ero rimasto sconcertato.
Forse non avevo visto bene, per via del riflesso del sole. Ma il dubbio era rimasto. Chinato a metà, mi ero guardato intorno con noncuranza e, raccolto il libro da terra, avevo dato un’altra sbirciatina. L’avevo quasi aperto quando una folata di vento aveva sbattuto insieme tutte le pagine, e Olga era sopraggiunta, rivestita d’acqua di mare. Ero rinculato come un paguro verso la sdraio, con un sorriso ebete e fasullo dipinto sulla faccia.
-Tu sta bene, mio Giovanni?- mi aveva chiesto dubbiosa e io in risposta avevo deglutito, guardandola con gli occhi sbarrati come se l’avessi vista allora per la prima volta.
Cos’era quel libro? Dovevo saperlo. Avevo insistito per portarle la borsa a casa. Intanto che lei si faceva la doccia, avevo aperto il libro, con mani tremanti.
Lì, ad attendere le mie incredule pupille, c’era la scena raccapricciante di un uomo che ne baciava un altro disteso sulla sabbia. Il testo sotto i disegni era in cirillico, ma non avevo certo bisogno di spiegazioni per capire di cosa si trattava.
Sperai che per lo shock non mi venisse un tumore al cervello.
Sentii il bisogno di parlarne con Ernesto.
-Eh, brava- disse lui con quel suo sorriso –si vuole sistemare. Ha visto come si sta a casa tua, e adesso studia per sedurti, vecchio mio- mi fece l’occhiolino.
-Ma… è successo così anche con la tua rumena?
-Ramona non è rumena, è albanese- ci tenne a precisare.
-Sì, ma è andata così?
-Figurati! Lei è proprio innamorata.
Messo in guardia dall’Ernesto, divenni ancora più sospettoso. Instaurai un certo distacco. Se lei se ne accorse, non diede a vederlo.
Invece le sue premure si facevano sempre più attente, mi sembrava che le sue mani indugiassero a lungo sul mio braccio, quando doveva aiutarmi. Prendeva sempre più confidenza.
Quanto al libro, non lo mollava mai, e io mi chiedevo se dovessi aspettarmi che mi saltasse addosso da un momento all’altro tendendomi agguati erotici nel corridoio.
Aveva dunque ragione Ernesto? Invano sondavo il terreno con domande del tipo:
–Che si legge, di bello, Olga?
Ma i miei pallidi tentativi naufragavano in risposte evasive, la più esauriente delle quali era:
-Non pronta, ora. Quando momento, tu saprai.
Così decisi di indagare.
Una sera mi appostai dietro la porta della sua camera spiando attraverso la serratura.
In quel momento le mie giunture si misero a scricchiolare tutte assieme, ma Olga, assorbita dalla sua attività, non si accorse di niente. Al di là del foro oblungo della toppa la vidi estrarre dall’armadio quello che in un primo tempo mi sembrò un canotto rosa. Lei vi appose le labbra, ci soffiò dentro e il canotto si trasformò in un manichino. Un manichino molto realistico, dotato di mutande con una protuberanza sospetta sul davanti.
Adagiò con delicatezza l’aggeggio sul letto, poi, a sua volta, ci si sedette sopra. Prese le mani di plastica di quell’affare e sospirò. A lungo, un sospiro da strapparti l’anima.
-Mio Giovanni- disse stringendosi al petto il manichino, che per tutta risposta emise un debole fischio –tu non lasciare me. Olga è qui, adesso, mette tutta sua energia per te.
Mio Giovanni? Avevano udito bene i miei padiglioni?
Ero veramente io l’oggetto del desiderio di quella donna?
Non riuscii a non trasalire, dall’altra parte della porta.
Poi, con un gesto di insospettabile rapidità lei si sfilò la camicetta offrendomi uno spettacolo che mi tramortì, mi fece cozzare la testa contro il legno duro dello stipite e mi lasciò sull’occhio l’impronta violacea della serratura che mi sarebbe durata per giorni. A quel punto non potei fare a meno di fuggire, ma le mie orecchie fecero ancora in tempo a sentire:
-No, Giovanni, tu lascia fare me. Non opporre resistenza mie mani, io fare te rinascere!
Se non sono morto d’infarto quella notte, vuol dire che morirò di qualcos’altro. Il cuore rimbalzava dolorosamente nel petto. Possibile? Avevo sentito bene?
La voce di mio padre urlava “le donne sono strane, strane…” e a me era capitata la più strana di tutte.
In spiaggia, l’indomani, mi sorpresi a fissarla, a seguirla con lo sguardo ovunque, accarezzavo la sua ombra sulla sabbia fingendo, come un babbeo, di costruire castelli. Sotto i miei occhi il suo costume svaniva e lei si rivelava come la sera prima nella sua camera.
Ridevo spesso, a sproposito, e la guardavo.
-Giovanni…
-Sì…?
-Io domani occupata… tu può fare a meno di Olga? Solo domani?
-Sì…
-Tu mio tesoro!- esclamò, e fece un movimento, come per darmi un bacio, ma si interruppe prima, imbarazzata.
Il rossore delle sue guance la rendeva la donna più bella del mondo.
Quella sera le comprai un anello, una cosa semplice, ma speravo andasse bene ugualmente.
Uscendo, incontrai l’Ernesto.
-La Ramona è scappata- mi disse lamentoso.
E giù a spiegare che non doveva lasciarla andare in discoteca da sola, lì aveva conosciuto un ballerino, suo connazionale, e adesso era andata a vivere da lui.
-Meno male che sua sorella passa questa sera per vedere come sto…
-Giovanni, io pronta ora a dire te cosa importante- esordì la mia dea. E io mi preparai ad ascoltare il miele delle sue labbra. Quali frasi meravigliosamente primitive avrebbe usato per dichiararmi il suo amore?
-Tu vieni mia stanza.
La seguii senza battere ciglio.
-Tu siedi su letto, sì.
Non chiedevo di meglio.
Nella tasca della vestaglia il pacchetto con il mio pegno d’amore era cosparso all’inverosimile delle mie impronte digitali.
-Tu sdraia su letto.
Mi stesi sperando che non mi venisse un ictus proprio in quel momento. Olga si avvicinò con un sorriso, guardandomi negli occhi.
-Olga… io- mi sollevai sui gomiti e le mie dita tremanti le tesero il pacchetto senza neppure avermi interpellato.
-Io parto, trovato nuovo lavoro, fatto esame bagnina ieri. Faccio vedere te come sono bravissima- disse sventolandomi sotto il naso il suo libretto rosso, dentro il quale una nerboruta assistente di piscina salvava la vita ad uno sventurato bagnante.
-Mia specialità è massaggio card…
Dopo dieci secondi di stordimento a labbra contratte in un ghigno amaro non riuscivo ancora a dire niente. Lo stomaco mi si chiuse per sempre.
Quando finalmente riuscii a guardarla, il suo sorriso aveva lasciato spazio ad un’espressione preoccupata.
Poi i suoi occhi caddero sul pacchetto. A mano a mano che la consapevolezza si faceva strada in lei, le sue iridi si velavano di compassione.
Allora mi posò teneramente le mani sul petto, spingendomi giù. Poi, con un sorriso dolcemente triste, tristemente dolce, sussurrò:
-Mia specialità è… respirazione bocca a bocca.
Sì, dopotutto mi aveva riportato alla vita, anche se era doloroso. Mancava solo l’ultimo soffio per risvegliarmi del tutto.
Chiusi gli occhi e attesi le sue labbra.
3° classificato: BENEDETTO MORTOLA di Camogli (Ge), con “Il segnalibro”
Avevo riportato sulla spiaggia quel libro, ma mi pesava trovarmelo in casa: mi dava l’impressione di conservare indebitamente un segreto.
La mattina prima l’avevo trovato dietro i libri di cucina sullo scaffale in soffitta.
I libri di cucina erano abbastanza datati, uno era addirittura la “Cuciniera Genovese” sul quale stuoli di ragazzine hanno imparato a gestire una fricassea di pollo, uno sformato di asparagi, una torta di zucca, una frittata di patate e cipolle ed un bel po’ di altri piatti, mentre diventavano donne. La mia era un’edizione vecchissima, un libro sul quale aveva già studiato mia madre. Lo avevo messo sullo scaffale ed era sempre rimasto lì, insieme a quei due o tre altri libri di cucina che non aprivo da molto tempo, non perché fossi diventata un’esperta cuoca, ma perché le mie due bimbe erano cresciute già abbastanza da non aver più voglia di mangiare quelle cose per me ancora famigliari, ma per loro già diventate “roba di una volta” e adesso, quando vengono a casa mia a pranzo, molto raramente, una pizza o al massimo una focaccia con il formaggio o un piatto di spaghetti con il pomodoro è tutto quello che mangiano. Per i miei nipotini poi, è impensabile tirare fuori l’armamentario per fare, che so, i ravioli o i tortelli o una focaccia con la salvia, dato che li vedo cibarsi di patatine fritte, insalate miste già pronte, panini farciti e merendine, merendine.
Cucino per me sola ed alla mia età non ho certo bisogno di consultare un libro per sapere come si prepara un piatto di gnocchi, quali verdure devo mettere in un minestrone o come si fa un budino con le uova e la buccia di limone nostrano.
Ma ieri mattina mi è venuta voglia di farmi uno zabaione; mia madre lo faceva spesso con delle belle uova fresche e così, dato che non ricordavo le dosi, sono andata in soffitta a prendere la Cuciniera Genovese, l’ho tirata fuori dallo scaffale e…
è stato allora che l’ho visto: questo libro che ora ho in mano.
Era rimasto dietro gli altri libri, lì, invisibile, da non so quanto tempo, forse da sempre, da quando ero venuta a vivere qui con mio marito. Un libro dalla copertina colorata con colori tenui, sbiaditi e con pagine che erano diventate gialle in fretta. Il titolo è inutile, l’autrice anche.
E’ uno di quei libri della mia giovinezza che mi riempivano di sogni dolci ed inebrianti come una promessa di quello che la vita mi avrebbe poi portato in dono. Nel voltare quelle pagine, scorrevano segreti ed emozioni, gioie e dolori che volavano incatenati fino al lieto fine al quale arrivavo a volte tutto di un fiato, rubando qualche minuto di più (se ci riuscivo) alla conca piena d’acqua da portare sulla testa dalla fontanella in fondo alla strada fino a casa, o dal mercato con mia madre per aiutarla con le borse della spesa, o quando c’erano le olive da raccogliere nelle fasce in quegli inverno freddi e le castagne nei boschi su in collina, quei boschi un tempo tenuti tutti bene e ora devastati dai cinghiali.
I sogni cominciano presto quando si è giovani e quando poi arriva una guerra allora corrono e galoppano insieme alla brutta realtà di tutti i giorni.
La Seconda Guerra Mondiale, per me, non è cominciata in un momento preciso. Tutti ne parlavano da tempo, ma sembrava una cosa molto lontana, però poi un giorno, avrò avuto quindici anni, ero in cucina a lavare i piatti, e ho sentito mia madre che piangeva.
Non l’avevo mai vista piangere, ma quel giorno piangeva, con un fazzoletto in mano e si girava con la testa dall’altra parte e usciva dalla sala e poi dal corridoio e si infilava nell’angolo accanto alla finestra della camera dei miei per non farsi vedere da me che la seguivo mentre mi asciugavo le mani nel grembiule. Mia madre non si voltò alle mie domande. Rispose singhiozzando con il viso girato verso il muro. La guerra era stata dichiarata e papà doveva partire soldato.
Mia madre si era sposata giovane, era nel pieno delle forze e la lontananza di papà non pesò molto nei primi tempi. La guerra sembrava una cosa facile: la Francia, la Grecia, l’Albania e la vittoria, sempre. Mio padre tornò un paio di volte a casa in licenza, diceva che era triste lontano da noi, ma era pieno di entusiasmo per come andava la guerra. Eravamo proprio invincibili.
Poi cominciò a cambiare tutto. Qualcuno cominciò a preoccuparsi perché non riceveva più lettere e i soldati e i marinai cominciarono a ritornare feriti o morti.
Capivi che c’era qualcosa che non stava funzionando, lo capivi dalle piccole cose, dalle donne sempre più spesso vestite di nero, dai prezzi che aumentavano, dalle poche feste patronali che lasciavano a tutti l’amaro in bocca, dalla paura che cominciava a crescere intorno e che arrivava come una lenta aria sporca, ogni giorno sempre di più.
Poi arrivò anche quel giorno di novembre, quando io presi questo libro che avevo appena iniziato e me ne andai sulla spiaggia a leggere.
L’aria era serena, sulla spiaggia non c’era quasi nessuno. Leggevo e intanto pensavo che Lino, il figlio del fornaio in fondo alla strada, aveva gli stessi occhi di Gualtiero, il giovane professore universitario del quale si era innamorata la protagonista del mio libro.
Leggevo, quando arrivarono gli aerei. Un rombo lontano che cresceva sempre più forte. Ricordo che misi un fiore come segnalibro e guardai il cielo. Dal profilo del monte che sovrastava la mia piccola città sbucarono gli aerei, alti tra le rade nuvole, e poi cominciarono a cadere le prime bombe.
Vidi lo scroscio sulle case della collina accanto al ponte della ferrovia, un lampo dopo l’altro e poi quei fragori che non avrei mai più dimenticato. Mi alzai tremante e cominciai a correre sulla sabbia della spiaggia deserta senza sapere dove andare, correvo un po’ avanti e un po’ indietro con il mio piccolo libro stretto in mano. Avrei voluto tornare a casa di corsa, ma laggiù, dove sapevo che c’era la mia casa, ora c’era anche un lungo fumo nero che saliva e c’erano ancora bombe che cadevano.
Sono tornata dopo quasi un’ora e ho trovato le macerie e le lacrime e le grida che sembravano mordere i muri crollati. La mia casa si era salvata, ma intorno sembrava passato un cavaliere dell’Apocalisse. Dove una volta c’erano case adesso c’erano rovine e oggetti conficcati dentro. Ricordo un guanciale impigliato sopra una trave spezzata che ondeggiava con quel suo bianco assurdo sull’immensa tragedia alla quale ero ritornata. Mia madre arrivò da dietro e mi abbracciò e poi mi portò con lei a scavare insieme agli uomini in mezzo al cumulo delle macerie dove fino a poco prima c’era la casa dei miei nonni. Ricordo le mani degli uomini che scavavano con qualche piccone e con pezzi di ferro e di legno. Ricordo le mani insanguinate di mia madre quando mi abbracciò e mi riportò alla nostra casa intatta ed era già diventato buio.
Non avevo più i nonni. E non avevo più Marisa, la mia amica di tre mesi più giovane di me che abitava nella casa di fronte ai nonni.
Ho pensato spesso a Marisa in tutti questi anni passati. Ho pensato al suo corpo che non è mai stato ritrovato, nel senso che hanno trovato qualcosa che forse era anche Marisa. La rivedo che corre mentre andiamo a prendere insieme l’acqua alla fontana. La sento che mi racconta di come Luigino la guarda quando si incontrano dopo la Messa. A volte penso a come avrebbe vissuta la sua vita se la sua vita gliela avessero lasciata vivere. Forse avrebbe avuto dei figli anche lei e avrebbero giocato con i miei, qui su questa spiaggia, e avremmo potuto stare a chiacchierare nelle sere d’estate mentre lavoravamo a maglia a fare calze di lana per l‘inverno e tra un punto e l’altro ci saremmo potute raccontare tante cose. Ci sono delle volte che Marisa la rivedo in tv, nei tg dell’orrore, con altre città lontane devastate da un’altra guerra e macerie su macerie e gente disperata che vaga alla ricerca di chi è rimasto sotto le case crollate, la rivedo nei loro occhi folli di dolore e di rabbia e mi scappa da piangere mentre cambio canale con il telecomando.
E stamattina sono qui con questo libro in mano e di colpo mi viene in mente una cosa: non l’ho mai più aperto da quella lontana mattina. Così ora lo apro adagio, e dopo poche pagine, trovo qualcosa che assomiglia ad un vecchio fiore rinsecchito che appena lo prendo tra le dita si sfalda e i suoi minuscoli pezzettini scuri cadono adagio sulla spiaggia e vedo anche che i granellini di sabbia che erano rimasti imprigionati da tanti anni tra quelle due pagine, cominciano a cadere anche loro e ritornano tranquilli nella sabbia che li riassorbe.
Adesso posso solo riprendere a leggere da dove ero rimasta.
Menzione speciale: ANTONIO ANTOELLI di Roma, con “Biblioteca popolare circolante”
Avevo riportato dalla spiaggia quel libro, ma mi pesava trovarmelo in casa: mi dava l’impressione di conservare indebitamente un segreto.
Poesie di Cesare Pavese: la copertina in tela grigia consunta in più punti, molte pagine gualcite, la sabbia che s’era depositata tra le pieghe della rilegatura, sembrava essere rimasto in spiaggia per giorni, forse dimenticato da qualche villeggiante.
A rigirarmelo tra le mani, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il profumo di Mila, quel misterioso alone speziato – lei si guardava bene da svelarne le essenze – che si lasciava dietro camminando, come una traccia acuta, talvolta pungente, e indecifrabile.
Allora, prima di trasferirmi a vivere in questa cittadina sul mare, coi libri degli altri tanti scrupoli neppure mi sfioravano: con Milena – ma tutti la chiamavano Mila, ed io mi ero adeguato -, con Mila nelle librerie praticavamo una sorta di autopromozione, tipo quella dei detersivi: prendi tre e paghi due. Noi alla cassa pagavamo due ma i libri li razziavamo cinque o sei per volta. Pochi erano i negozi forniti di quei varchi elettronici che leggono la targhetta a barre ottiche della merce e trillano di sofferenza, per l’incasso a rischio, se cerchi di svicolare senza pagare. Telecamere a circuito interno di la da venire, fantascienza quasi. Insomma, la vigilanza era ancora affidata in prevalenza al fattore umano, per questo sceglievamo sempre librerie con poco personale, nelle ore di massimo affollamento, con una divisione dei compiti che, più che ad esigenze funzionali, rispondeva a una precisa gerarchia: a me, gregario, oltre a tener d’occhio in modo impacciato e maldestro commessi, eventuali vigilanti e altri clienti (“Ti fai accorgere che li controlli, nella vita ci vuole professionalità in tutto !”, mi aveva strigliato Mila in più di un’occasione ), toccava recarmi alla cassa con “il dichiarato”, la punta dell’iceberg, mentre Mila, il capo, guadagnava l’uscita con il “sommerso” ben inguattato nella sua capace tracolla in mezzo a riviste, beauty case portatile, e un pacchetto di assorbenti.
Che Mila fosse il capo riconosciuto, e non solo per me, rientrava nell’ordine naturale delle cose: bella, elegante, altera, arcisicura di sé: nata per comandare. Insomma, la sua qualità di capo si avvertiva a pelle. Anzi, a occhio: perché ciò che più colpiva in lei erano gli occhi, quei begli occhi grigio-nocciola, e quel suo sguardo fermo, un po’ socchiuso, immune dal presente. Uno sguardo visionario, l’avrei definito, che scavalcava le cose di oggi per arrivare direttamente a un futuro remoto e idealizzato, che si sarebbe certamente avverato, anche se il quando sfuggiva a qualsiasi ragionevole previsione.
Del resto, la distribuzione dei libri in borgata, anzi la “biblioteca popolare circolante” alla quale avevamo dato vita , non faceva che confermare il ruolo di Mila : nella fumosa saletta interna del caffè che all’ occorrenza ci ospitava – eravamo costretti ad appoggiarci a “strutture esterne”, dopo che Liborio, il segretario della sezione, senza tanti giri di parole ci aveva detto che non “si sarebbe mai prestato a legittimare il maneggio di refurtiva “ – era Mila a stabilire chi doveva leggere cosa, e a consegnargli materialmente il libro, si trattasse di nuove o vecchie “accessioni” : lo decideva lì per li, con una certa sommarietà, talora sulla base di qualche precedente scampolo di conversazione con il “beneficiario”, talaltra in forza solo di uno spicciativo giudizio estetico (dopo, con me, sfoggiava una civettuola punta di vergogna per essere stata così “lombrosiana”, anche se a fin di bene), comunque raramente sbagliando, considerando il largo giudizio positivo che circondava quella sua estemporanea vocazione di consulente letteraria.
Nelle “acquisizioni“ la preferenza doveva andare a libri “impegnati, educativi ed accessibili, possibilmente attenti alla realtà italiana“, era questa la ferrea consegna di Mila, esemplificata nella “Storia “della Morante, di cui avevamo messo in circolazione almeno una dozzina di copie. Guai a trasgredire: me n’ero accorto quella volta che, tra gli ultimi accessi alla biblioteca circolante, con crucciata sorpresa aveva scoperto le poesie di Pavese, di cui mi sapeva appassionato lettore. E, cosa che la indispettiva ancor di più, era tra i libri regolarmente passati alla cassa . “Lavoriamo sul territorio, in un quartiere di poveracci, gente che ha letteralmente il problema di cosa mettere in tavola : a chi c…. vuoi che interessi un poeta che s’inzuppava compiaciuto nel suo malessere, fino ad ammazzarsi per un’ attricetta americana ?”, mi aveva assalito, sventolandomi le poesie sotto il naso, e non si capiva cosa biasimasse di più in Pavese, se il suicidio, o averlo commesso per una yankee.
Era un volume elegante, che nella sovracopertina riproduceva un Van Gogh.
Proprio come doveva essere in origine la copia malconcia rinvenuta in spiaggia .
Anche allora, leggendo Pavese, provavo la sensazione di un’appropriazione indebita, e non sapevo se riguardava il suo mal di vivere, riversato nelle poesie, o la pretesa di rispecchiarvi il mio.
Poco dopo quella reprimenda, Mila scomparve, e la polizia si fece vedere in sezione, procurandomi qualche apprensione. Ma non c’era alcun collegamento coi libri. Era successo che Mila aveva “scavallato” come aveva lapidariamente spiegato Liborio, abbottonato come al solito, un po’ per temperamento, molto per zelo cospiratorio con Botteghe Oscure.
I mormorii di sezione tradussero quel criptico “scavallato”: Mila stava con un piede nella legalità e l’ altro nella lotta armata, e per questo, appena in tempo, s’era rifugiata in un paese “che co’ l’Italia nun cià l’estradizione”. Altri commenti furono riservati allo scrivente, “che le stava dietro dietro, come un cagnolino, si vedeva che era cotto“, ripuliti dall’abituale ruvido romanesco, ritenuto poco adatto alle pene d’amore. Ma questo lo seppi di rimbalzo, parecchio tempo dopo.
* * *
Ci sono volute tre settimane prima che mi azzardassi a toccare di nuovo il libro, attento ad evitare che qualche residuo di sabbia cadesse sul tappeto di casa.
Ho cominciato a sfogliarlo dall’inizio, separando le pagine che la salsedine aveva incrostate a mazzetti. Mi si è subito rivelato un largo timbro rettangolare, dove, insieme a uno stemma cittadino, campeggiava la dicitura: ”Comune di * – Assessorato servizi sociali – Biblioteca Popolare Circolante“, e accanto numero d’inventario e codice di schedatura.
Non restava che recarmi al più vicino ufficio postale e rispedire il libro al legittimo proprietario, con la consolazione di sapere che agli abitanti di * Pavese non manda di traverso i pasti, come succedeva in borgata, stando a Mila.
Poi però mi ha aggiogato una istintiva, irragionevole certezza : Mila. Appianati i trascorsi con la giustizia, è tornata: forse ha letto “Verrà la morte” e si è riconciliata con Pavese (magari anche con Constance,”l’attricetta americana”) e ha scelto i suoi versi per una seppur tardiva risposta ai miei sentimenti, affidata a quel libro, sottratto alla biblioteca di * con l’antica tecnica collaudata di un capo che può anche fare a meno di gregari. Un libro ormai introvabile, un cimelio editoriale, quasi, nella biblioteca, come suo unico segno, sarà rimasta la scheda di catalogazione, che – immagino – recita più o meno così: “PAVESE, Cesare : Poesie edite e inedite,Torino, Einaudi, 1962, pagg.254”, e, apposta di traverso, una vistosa stampigliatura : NON DISPONIBILE.
Prima o poi, forse alla prossima estate, Mila tornerà a cercare entrambi: il libro volutamente dimenticato e me.
Assaporo la dolce euforia di un’attesa appagante.
Come mi succedeva da ragazzo, quando tra un flirt estivo e la successiva delusione veleggiavo per un anno intero sopra nuvole dorate, lieve dalla terra come i fidanzati di Chagall.
Mi rendo conto che il ritorno amoroso di Mila è una fola, un’idea strampalata, che solo ad accennarla in giro c’è da farsi ridere dietro per una settimana: “non ha più l’età per fare il sognatore“, ghignerebbe con commiserazione qualcuno di quelli che all’epoca mi accostavano a un cagnolino servizievole .
Ma adesso Mila è nell’ aria, con le poesie di Pavese è tornato il suo profumo speziato, e quel suo sguardo ancor oggi rivolto solo al futuro, ci giurerei, anche se il tempo ,al futuro , in un amen ha già mangiato trent’ anni .
E’ dolce la compagnia di Mila, senza tema di messe in riga, non voglio rinunciarvi.
All’ufficio postale andrò domani, tra una settimana, tra un mese …forse mai.
Menzione speciale: FIORELLA DI LORENZO di Milano, con “Tango a modo mio”
Fermo
Fuori è tutto fiori e sole.
Sembrerebbe quasi primavera inoltrata se non fosse per la luce.
Non mi sarei mai aspettato di saper cogliere la differenza tra una stagione e l’altra dalla LUCE, io, che fino ad un anno fa non sapevo che tempo facesse sino all’ora del meteo in TV.
Osservare quello che succede fuori dalla finestra mi fa sentire romantico, altro aspetto che ho scoperto di possedere oltre a questo sorriso un po’ ebete che mi si stampa in faccia e che non riesco a cancellare.
Marco, un mio collega, mi ha chiesto oggi a pranzo se per caso non fossi entrato in una di quelle associazioni pseudopsicologiche che promettono di restituirti il tuo mondo perduto e mentre la tua mente parte per cercarlo ti svuotano il portafogli.
Alla fine gli ho detto che stavo attraversando un “periodo Zen”.
“Che roba è il periodo Zen?” – mi fa lui guardandomi da sopra gli occhiali.
“Qualche tempo fa ho letto un articolo in Internet che aveva come oggetto il “periodo Zen”. In pratica questo periodo “Zen” cascherebbe nella vita di un individuo, almeno una volta, sicuramente dopo i 35.”
“Te lo stai inventando” – mi dice spezzettando quel che resta di una polpetta al sugo.
“Ti pare che me lo inventi?” – “L’articolo descriveva anche alcuni sintomi quali sorriso da ebete, sguardo vacuo, eccessiva attenzione a cose e persone mai calcolate prima eccetera” .
“Ah” – “Adesso capisco perché quando ti parlo non mi ascolti” mi risponde lui lievemente soddisfatto.
“Beh, no.” – E’ che l’80 % di quello che dici non è altro che il 40 % di quello che mi hai detto il giorno prima più un altro 40% che conosco già” – “ Caffè??”
Chiaramente l’articolo sul periodo Zen non esiste.
Però tornando in ufficio, ho visto Marco specchiarsi in una vetrina. Avrà voluto vedere se aveva anche lui il sorriso da ebete.
Nella mia vita passata sono stato un tipo pratico. Qualcuno potrebbe usare la definizione impropria “terra-terra”. Sì insomma uno di quegli individui che trovano nel lavoro, molto lavoro, la famiglia e la partita di calcetto la propria dimensione.
Io non lo chiamerei terra-terra. Lo chiamerei vivere quasi come fossi un allevatore di maiali che purtroppo non sono.
La filosofia del vivere quasi come fossi un allevatore di maiali (che purtroppo non sono) non prevede lunghe elucubrazioni esistenziali sul perché si sta al mondo davanti ad una tazza fumante di caffè in qualche locale sui Navigli né tanto meno prevede altrettanto lunghe cene a base di tofu e rivendicazioni sentimental-sociali appollaiati al trespolo della cucina mente tra la ricostruzione di una telefonata e l’interpretazione di una e-mail la pasta nel piatto s’è fatta colla che nemmeno l’idraulico liquido saprebbe operare miracoli in tal senso.
Nossignore.
Vivere quasi come se fossi un allevatore di maiali che ribadisco, purtroppo non sono, significa seguire ciò di cui abbiamo davvero bisogno: mangiare, bere, sesso e relax.
Tutto il resto è cornice.
Cristina, mia moglie, è una cornice. O meglio, non è che lei sia una cornice diciamo che crede che la cornice sia notevolmente più importante del quadro.
Cristina esce alle 8,00 del mattino per andare al lavoro ma si è alzata alle 6,00 per riordinare la casa, lavarsi, pettinarsi, truccarsi, preparare Lorenzo, stendere e ricordarmi di ricordarle di ricordarmi di chiamare mia madre.
Finge di avere scarsa memoria quando si tratta di ricordarsi che al giovedì gioco a calcetto ma ne sfodera una elefantiaca quando si tratta di riesumare frasi che avrei detto (da ubriaco? Al liceo quand’ero un 18 enne borioso e il resto non posso dirlo? Mentre mi tortura cercando di farmi i massaggi?? ) e che comunque non ricordo più.
Ogni tanto a cena mi racconta della sua giornata partendo dal dettaglio di un episodio accaduto che come minimo coinvolge 4 o 5 soggetti OMETTENDO di raccontarmi il perché dell’accaduto.
Il bello è che s’inalbera tutte le volte perché dice che mugugno invece di ascoltarla.
Il che è naturalmente vero, ma dico io, come si fa a dare la risposta giusta se non ti hanno nemmeno fatto la domanda?
Cristina è capace di descrivermi quella cosa fantastica che ha visto nel tal negozio e che vorrebbe tanto comprare perché è in promozione ma non per tanto (non per tanto quanto???) e va avanti per una settimana oppure un mese fino a che non mi decido ad andare a vederla e poi quando siamo per strada nel traffico più selvaggio del sabato pomeriggio in cui Signore e Signori, si aprono le gabbie e quando finalmente arriviamo lì scopriamo che in realtà la promozione è finita da una settimana e che naturalmente è colpa mia.
Che sono terra-terra. E avrei dovuto fare l’allevatore di maiali.
Per farla breve e’ proprio dal concetto base “quadro/cornice” che si sviluppavano le nostre più grandi discussioni: chi doveva comprare il pane, vendere il bilocale per prendere un trilocale, dove andare in vacanza, il calcetto e infine Lorenzo.
Nostro figlio.
Adesso ha tre anni ed ha imparato già a stare al mondo: sorride quando guarda le Veline e si lamenta insofferente quando Cristina cambia canale per seguire programmi non pensati per persone non pensanti.
Va al Nido da quando aveva 1 anno e mezzo e nonostante Cristina si lamentasse che “è sempre malato e che non gli danno da mangiare abbastanza” (la conversione dalle misure Cristina a quelle comuni dice che quello che mangia Lorenzo è più che sufficiente per uno che non vuole rischiare di diventare un obeso) trovo che sia “avanti”.
Io non ero così sveglio alla sua età, non che me lo ricordi e comunque all’asilo non ci sono andato perché puntualmente vomitavo sulla gonna della suora.
Per il nervoso s’intende, mica per mancanza di rispetto verso la suora.
Ogni volta che lo rivedo mi sembra sempre più grande, più adulto. Sarà perché non ci sono spesso e ci sono stato ancor meno prima.
Tipo un anno fa. Quando ero il Direttore Vendite della Prisme e mi sparavo Milano-Parigi-Parigi-Milano almeno 3 volte a settimana.
Una volta ho anche rischiato di restarci secco che se non fosse stato per il Responsabile della produzione a quest’ora starei nel Paradiso dei “quasi allevatori di Maiali “ a guardare in giù.
Come al solito avevo mangiato sull’aereo qualche schifezza confezionata di plastica che con l’aria condizionata dell’aereo e della macchina doveva aver contribuito a formare un bolo granitico nello stomaco.
Chissà perché quella sensazione mi faceva venire in mente un mio collega un po’ filosofo che tutte le volte che si usciva a cena e lui puntualmente si strafogava, una volta alzatosi da tavola si massaggiava la pancia e diceva: “stavolta sono sicuro, è un podalico”.
E mentre guardavo i grafici che il Responsabile della Produzione mi sventolava davanti sentivo che ormai il “podalico” era vicino. L’ultima cosa che mi ricordo è il suo faccione rosso che con le mani giunte in alto quasi a tenere una spada mi si avventava contro.
Grazie a lui oggi sono qui.
Anche se non sono più il Direttore Vendite della Prisme.
Anche se lui come responsabile della produzione faceva pietà ma sono certo che avrebbe un futuro come volontario sulle ambulanze.
Bisognerà che glielo dica. Un giorno.
Un sacco di cose gli dovrei dire.
Prima tra tutte che è colpa sua se un anno fa la mia vita ha preso la china.
Quale, devo ancora capirlo.
Un passo indietro
Oggi sarà una giornata di merda. Lo so.
Ho passato tutto il fine settimana a girare i dati sopra e sotto a tirarli ad arrotondarli ma non c’è un cacchio che tenga. Fanno veramente schifo.
So già che il mio Capo nonché Direttore Generale della Prisme non dirà nulla fino all’ultimo, dopodiché si alzerà in piedi con il dito dritto e mi vomiterà addosso tutta una serie di insulti in dialetto stretto che si concluderanno con la solita frase biascicata a denti stretti prima di scomparire dietro le porte dell’ascensore: “2-1 c’est la merd!”.
Non gli è mai andato giù che li avessimo battuti ai Mondiali. E se c’è una cosa che i francesi non sanno fare è perdere con classe.
Mentre penso alla riunione delle 14 e sono in coda mi guardo nello specchietto.
I miei capelli sono talmente lunghi che ai lati hanno assunto una forma vagamente aerodinamica. Cerco di sistemarli con le mani ma proprio non ci stanno.
Bisognerà che vada da un parrucchiere prima o poi. L’ultima volta che Cristina ci ha messo le mani dicendo che tanto lo aveva già fatto ho dovuto rasarmi quasi a zero.
E tanto per cambiare eravamo in Gennaio.
Ancora prima di uscire dall’ascensore avverto nell’aria l’adrenalina. Sono già tutti sclerati, sono già tutti in preda a crisi di ansia e panico. Metà dell’azienda sta vomitando nel cestino sotto la scrivania mentre l’altra metà si sta calando di ansiolitici e calmanti vari.
I miei uomini saranno di certo rintanati in sala commerciali a verificare e riverificare i dati, importunando di tanto in tanto le ragazze dell’ufficio vendite perché stampino questo o quell’altro ed io vorrei dirgli che tanto non serve.
Lasciatele stare. Sono impiegate non prestigiatori, non tirano fuori, in questo caso i numeri dal cappello. O almeno non ancora.
Non ho una segretaria perché da noi solo il Direttore Generale ha la segretaria.
Che non è giovane e non è nemmeno gnocca.
Anzi, ha un carattere pessimo e come i francesi manca totalmente di senso dell’umorismo.
Si chiama Sofia. Anche il nome ha la puzza sotto il naso.
In compenso ho Alessandro Bono, il mio braccio destro, il mio faro nella nebbia, il mio fratello di nottate tra numeri e calcetto.
Ha 38 anni come me e suona il basso per sport. E’ sposato con Alice che ha conosciuto in Prisme quando lui era un giovane venditore rampante e lei una stagista al marketing.
Sono belli. Stanno bene. Mi danno l’idea di amalgamarsi senza fatica, senza nevrosi, senza dubbi.
Di Alessandro mi fido, mi ricorda un po’ Russel Crowe in “Il Gladiatore” quando parla con i suoi uomini, è talmente convinto e dritto come un fuso che non posso far a meno di intonargli la colonna sonora quando la riunione finisce.
E’ da lui che vado per calmarmi. Adesso.
“La intoniamo oggi o battiamo in ritirata subito?” mi dice quando mi vede entrare.
“Dipende con quanto senso dell’ironia arriva oggi Le Gaud.”
“Se riattacca con la storia del 2 a 1 lo attacco al muro, ti avverto” mi dice Alessandro puntandomi la matita contro. “Che cos’hai in testa, un ufo? Perché non vai a sistemarti cazzo?”
Dimenticavo: Alessandro ha uno strano senso dell’ordine, va bene tenere la sacca del calcetto con la roba dentro ormai incartapecorita ma i capelli e la barba , no. Devono essere in ordine.
“ Vai da un parrucchiere subito, c’è n’è uno dentro il Centro commerciale qui in parte”
Un’altra delle sue caratteristiche: dare indicazioni precise. “Qui in parte” per lui è un’indicazione più che sufficiente ad indirizzare una persona nel luogo desiderato.
Siccome so di essere indecente decido di andarci. Magari dopo il caffè.
Alle 11,30 siamo già come quei polipi appesi alle piante di fico ad essiccare che ogni tanto si vedono in Grecia o in Sicilia. Mosci, bagnati e rassegnati.
Nessuno dei reparti può dirsi salvo.
La produzione è in ritardo di un mese sulle consegne della linea di punta, e su altre referenze siamo in rottura di stock, il recupero crediti segnala un aumento esponenziale dei giorni di esposizione globale, le vendite sono sotto la media pari periodo anno precedente del 40%.
Possiamo dire che non è colpa nostra. Possiamo dire che questa politica commerciale noi non l’abbiamo scelta ma ce la siamo trovata.
Diminuirebbe l’entità della nostra presunta colpa? Io, non credo.
Queste cose sono come il Cubo di Rubick, puoi rigirartelo tra le mani per ore ma se non hai il metodo e un po’ di culo, puoi continuare a rigirartelo tra le mani per tutta la vita.
Mentre penso al Cubo di Rubick sento di non riuscire a respirare, devo uscire, devo alzarmi perché mi sto innervosendo e questo ha sempre effetti nefasti sulle cose e persone. Scollegare il cervello dalla bocca non va bene durante una riunione coi capi.
Vado a tagliarmi i capelli al Centro commerciale “ lì in parte”.
A parte che potrei prendermi la broncopolmonite con tutti questi sbalzi di temperatura. Oggi è il 1 di Marzo e ci sono 22 gradi, non so perché dentro a questa fucina di frustrazioni che la gente comunemente chiama “centro commerciale” hanno già acceso l’aria condizionata.
E’ curioso, a guardarsi intorno sembra che la povertà non esista. Scrivono continuamente articoli sullo stato allarmante di povertà in cui versa l’Italia e poi guarda qui, è pieno di gente che compra a ciclo continuo.
Mentre cammino sotto alle luci al neon guardo fuori dai vetri. Vetri sul soffitto, vetri alle pareti, un mondo ovattato che divide il rumore dal rumore, che filtra la luce che non ti fa capire che tempo fa, che non ha spazio né tempo e parla con la pubblicità.
Mi sento un pollo da allevamento. Agitato. Strangolato.
Dove diavolo è il parrucchiere?? Alessandro ha certamente sbagliato centro commerciale, qui più che slip e creme qui non vendono.
Accanto ad un enorme chiosco con tanto di gazebo e tavolini modi pic-nic (Dio che tristezza) c’è il parrucchiere. Da DONNA. Mi sento disperato.
Perché lo ascolto? Perché credo ancora che Alessandro sia attendibile?
Mentre mi volto per tornare in ufficio vedo che dentro al salone del parrucchiere
c’ è un tizio con la gazzetta in mano che aspetta.
Forse c’è una speranza. Guardo l’orologio. E’ mezzogiorno, mezz’ora e sono fuori.
Mi fiondo dentro, trafelato e compiendo un mezzo giro su me stesso alla ricerca di qualcuno mi ritrovo davanti questa similbionda lampadata con le unghie lunghe e squadrate che mi chiede sorridendo “Cosa deve fare?”.
“Secondo lei cosa devo fare??” vorrei risponderle ma in fondo sono un bravo ragazzo e le sorrido di rimando mentre le dico -“Devo solo darmi una sistemata”.
Lei mi guarda con la testa un po’ inclinata e poi mi fa accomodare al lavateste, accanto ad una signora piena zeppa di carta stagnola.
Noi uomini non dovremmo assistere ai “lavori in corso”. Voglio dire, una bella donna è una bella donna, ma vedere il “prima” di diventarlo non è poi così affascinante.
Anzi. Fa paura.
Mentre fisso la stagnola sulla testa della signora delle dita mi accarezzano i capelli.
Dallo specchio di fronte a me vedo una brunetta con i capelli corti e una mollettina in testa a tenere fermo il ciuffo.
Ha un bel fisico, dal mezzo busto che vedo e poi sotto il grembiule ha questa maglietta che in effetti è un po’ scollata.
Come si fa a non guardare??
Ho sempre pensato che fosse diabolico quel gesto che molte donne fanno quando si mettono delle gonne corte e passano il tempo a tirarsele giù o quando si mettono le magliette scollate e passano il tempo a tirarsele su o si mettono qualcosa davanti quando si devono piegare. E’ peggio, voglio dire.
Quando mi lava i capelli lo fa gentilmente, massaggiando le tempie, la nuca, facendo pressione con le dita sulla fronte.
E’ bellissimo. Vorrei stare qui per sempre. Mi sciacqua delicatamente, senza gesti bruschi, senza fretta.
Quando mi chiede di alzarmi non sento, ho gli occhi chiusi e sono in un altro mondo dove non ci sono riunioni ed è tutto facile.
“Mi scusi” dice lei dopo avermi asciugato “si puo’ accomodare là, io arrivo subito” e mi indica una sedia all’angolo del negozio.
Mi sento un po’ cretino, ma non capisco bene perché. In questi posti loro comandano e tu esegui. Bisogna stare attenti.
Mi siedo e la guardo dallo specchio.
Ha una bella figura, un bel fondoschiena. Non è bellissima ma ha qualcosa quando si muove che sembra riempire tutti gli spazi. Il suo sorriso è malizioso ma al contempo sincero.
Mi fa pensare che se le chiedessi di uscire mi direbbe di sì, senza pensarci.
Il cellulare rompe brutalmente le mie fantasie. E’ Alessandro Bono.
“Pronto.”
“L’hai trovato allora?” mi chiede mentre mastica qualcosa.
“Fai schifo a dare indicazioni, la prossima volta mi porto il navigatore”
“Le Gaud arriva con un’ora di ritardo, la sua segretaria ha appena chiamato”
“Ah bene, così magari ho il tempo di mangiare qualcosa”
“Quante probabilità ci sono che cada?” mi chiede Alessandro sempre biascicando.
“Cos’è che dovrebbe cadere??”
“Il suo aereo privato”.
Mi viene da ridere e la brunetta si sta avvicinando con un paio di forbici in mano, ha in vita un piccolo grembiule con spazzole e altri aggeggi che ondeggiano al ritmo dei suoi fianchi. C’è scritto Betty sul grembiule.
“Sì ok Ale, ci vediamo tra 20 minuti” e riattacco.
Lei mi si mette dietro, mi passa le mani tra i capelli e mi dice sorridendo: “Come li facciamo?”.
Quando ha finito di phonarmi, nella mia testa abbiamo già fatto tutto, in ogni modo, in ogni luogo e adesso sazi, ci salutiamo.
E’ stato bello, Betty.
Prima di tornare in ufficio mi fermo al chiosco virtuale con i tendoni rossi per prendere un toast e mentre sono in coda vedo lei, Betty, che prende un caffè .
Sta parlando con il ragazzo che fa i caffè.
Non ha un brutto profilo e poi ride spesso. Sembra serena.
“Due euro e 50 grazie” mi dice la cassiera. Ma evidentemente non sento.
“Signore?!” mi ripete lei mentre alle mie spalle qualcuno sbuffa di impazienza.
“Certo, mi scusi” – “Quant’è??” Coglione. Sono un coglione.
“Due euro e 50, grazie” dice lei guardandomi seccata
Frugo nelle tasche, niente. Sono costretto a darle 50 euro.
“Non ha cinquanta centesimi?” dice battendo cassa
“No, mi spiace”
“Ecco a lei, buona giornata” dice mentre mi rende scontrino, monete e banconote in un mucchio selvaggio sopra un piattino minuscolo – “Prego a chi tocca??”
Mi sposto mentre tento di rimettere in ordine il resto, la moneta mi cade come succede sempre quando ho fretta e c’è troppa gente intorno. Il che mi fa incazzare ancora di più.
“Che palle!”
“Oggi non è la tua giornata vero?” mi dice Betty porgendomi le mie monete
Ha gli occhi scuri, grandi, e qualche ruga di espressione intorno.
“No. In effetti no.” – “Grazie” dico prendendo la moneta. Mani lisce, gentili.
“Quando sei nato?” mi chiede guardandomi senza incertezze.
“Oh, beh. Parecchi anni fa”- (Idiota!)
“Intendo il mese”- mi dice lei e si mette a ridere. Deve aver capito che sono un idiota.
“Certo. Il mese. Sono di maggio. Cinque maggio.” Tento di riprendere controllo sulla mia gestualità che deve sembrare sincopata.
Non so dove ho messo le monete, mi guardo intorno. Adesso ho le mani piantate sui fianchi. Vorrei non averle le mani, in certi momenti sono di troppo.
“Toro. Si capisce subito” – “Questo è un anno fortunato per i Tori” lo dice con tanta convinzione che sembra quasi seria.
Ha le labbra rosa, pronunciate ma non volgari. Le sto fissando e me ne rendo conto ma non posso fare a meno di farlo.
“Sei in pausa pranzo?- Mi chiede sorridendo con l’aria di chi sa di essere guardata.
“No, cioè si. Quasi” – “Volevo mangiare qualcosa al volo e poi tornare in ufficio” mi ricordo in quell’istante che devo prendere il toast e che non so dove ho messo lo scontrino.
“Ti faccio compagnia. Ho ancora qualche minuto di pausa” e mentre lo dice mi appoggia la mano sul braccio, poi mi guarda e capisce che sono frastornato, imbarazzato completamente in panico.
Perché mi fa questo effetto??
“Non trovi lo scontrino vero?” e il suo braccio fa il giro, intorno al mio. Poi mi lascia e fa un passo indietro allungando la mano “Piacere di averti conosciuto Toro, spero di rivederti”.
Le stringo la mano. La guardo allontanarsi, ondeggiante e naturale in quello spazio.
Le vorrei dimostrare che so essere anche molto più sicuro di così ma resto lì impalato davanti al chiosco con le tende rosse a guardarla andar via.
Ciao Betty.
Ciao toast.
Nel mezzo del vociare mi sento pesante, inchiodato alla terra. Inquieto.
Adesso mi muovo perché c’è una riunione ed io non posso permettermi di star qui come un idiota a guardare una parrucchiera che flirta con i clienti.
Purtroppo.
Alle 21,00 la sala riunioni sembra un campo di battaglia.
Ci sono ovunque sul tavolo tazzine di caffè consumati e non, bottiglie d’acqua, fogli e grafici abbandonati, penne prive di cappuccio, pallottole di carta a quadretti giacciono ai piedi dei cestini, le sedie sono rivoltate all’esterno, il proiettore è ancora acceso e il logo windows viaggia sereno in qua e in là sulla parete.
La filp chart mostra dei numeri inquietanti e quello che succederà alla Prisme Italia è proprio lì sotto, dove la curva discende. Sembra talmente curva che sembra inabissarsi oltre il foglio, sotto il pavimento, giù per le scale in mezzo alla strada. Al centro del mondo.
“Beviamo qualcosa?” è la voce di Alessandro Bono, dal fondo della sala.
Si è tolto la cravatta ed è senza giacca. Mezzo stravaccato sulla sedia si rigira la matita tra le mani. E’ stravolto.
Mi passo le mani tra i capelli freneticamente, mi rilassa.
Mi sembra di togliermi dalla testa i problemi per una frazione di secondo.
Però quando smetto sono ancora lì. Dodici anni di lavoro per nulla. Sta andando tutto a puttane e la colpa non è nostra. Noi dobbiamo pagare per gli errori degli altri.
Noi siamo il capro espiatorio di un metodo non deciso da noi e che ci porterà a chiudere in negativo. E poi saranno dolori.
“Al diavolo questi francesi di merda”
“Fanculo la Marsigliese e la Quiche Lorraine” risponde Alessandro
“Fanculo le baguette e la Tour Eiffel” mentre lo dico mi viene da ridere
“Chi cazzo puo’ avere un monumento così stronzo se non loro?” – “Sembra una supposta gigante” Alessandro ha le lacrime agli occhi.
Ci alziamo e ce ne andiamo. Lasciando tutto acceso.
Parecchie ore più tardi, mentre faccio ritorno a casa mi sento incazzato.
E’ come se avessi sulle spalle 20 anni in più di vita e zero gratificazioni. Probabilmente tra qualche tempo dovrò andarmene prima che i francesi mi pongano il benservito e questo mi fa salire il sangue al cervello.
Pagare per gli errori altrui non mi è mai piaciuto e certamente non è un compromesso che sono disposto ad accettare.
Anzi, dovrei dire che questo è l’ennesimo compromesso che NON SONO disposto ad accettare.
Ho quasi 39 anni, una moglie, un figlio, una tartaruga , una macchina ed un mutuo da pagare almeno per i prossimi 10 anni.
La vita.
Quand’ero bambino ero convinto che io avrei cambiato le cose. Nel mondo intendo.
Non so perché ma ero convinto che a volere intensamente qualcosa si finiva per ottenerla.
Tutto perché una sera ero rimasto a casa da solo e mentre aspettavo che mia madre rincasasse era andata via la corrente. Ricordo di essermi precipitato sul balcone per vedere se lei arrivava, fissavo il portone e mi ripetevo che da lì a qualche momento sarebbe comparsa. Sarebbe arrivata. E lei arrivò.
Il bello di tutta la faccenda è che mentre con gli anni la paura del buio è svanita, la sensazione di onnipotenza, no.
Da qualche cassetto della mia testa esce Betty, con la sua mollettina in testa e le labbra rosa. Ho voglia di stringerla e di non raccontarle nulla di me né sapere nulla di lei.
Ho voglia che sia mia, per un minuto oppure un ora e che poi sparisca da dove è arrivata.
Che razza di nome è Betty?
Giravolta
Per la prima volta vado in un Motel. E’ poco lontano da Milano, nascosto nel verde. Sembra di essere in un condomino di villette monofamiliari con l’unica differenza che il posto auto è coperto da un tendone.
Betty è in bagno e mentre guardo i suoi vestiti a terra ripenso al modo in cui siamo finiti qui.
E’ stato un attimo.
Sono andato a prendere il detersivo dopo che Cristina mi ha chiamato dicendomi se potevo farle questa cortesia e mentre pagavo alla cassa l’ho vista uscire dal suo negozio.
Doveva aver finito il suo turno perché aveva il soprabito e le scarpe con il tacco. Una piccola borsa dorata le dondolava sulla spalla.
Lei mi ha guardato e mi ha sorriso rallentando il passo.
Siamo usciti assieme, io con il mio sacchetto del supermercato arrotolato al polso e la borsa porta pc a tracolla.
Non sapevo che cosa dirle, cioè, avrei voluto ma, non lo so, in realtà non avevo nulla da dirle se non che mi piaceva, mi attirava e avrei voluto davvero tanto portarmela a letto.
Ma non si puo’ dire ad una donna una cosa del genere giusto?
Sbagliato.
E’ stata lei a dirmelo. Parola per parola quello che avevo pensato una frazione di secondo prima.
Per tutto il tragitto non abbiamo parlato. Non abbiamo parlato nemmeno quando ci siamo trovati nudi uno davanti all’altra.
Abbiamo fatto parlare loro, i nostri corpi, che sapevano cosa dirsi a quanto pare e non solo lo sapevano meglio di noi e più di noi ma anche in modo più completo.
Senza esitazioni né pause.
Loro si conoscevano. Non so come sia potuto succedere ma è stato come se si fossero appartenuti da sempre.
E adesso che sono lontani, non ho nulla da dire a Betty. Lei che ora esce dal bagno senza nulla addosso ed è naturale, a suo agio.
Chi è questa donna che si sdraia vicino a me e mi guarda? Quanti anni ha? Si chiama davvero Betty?
“Da quanto sei sposato?” mi chiede mettendosi su un fianco.
Faccio un lungo sospiro.
“Da sei anni” – “ Tu sei sposata?”- vorrei che mi dicesse di sì.
Che non mi chiamerà mai nel cuore della notte né bollirà in pentola l’ipotetico coniglio di mio figlio.
“No. Ma lo sono stata fino ad un anno fa”
Ha dei modi rilassanti, mai tesi. Questo mi piace, mi fa sentire tranquillo. Mi dice che non devo preoccuparmi. Ma forse mi sbaglio. E’ una tattica. Dopo si rivelerà un mostro, una stronza senza fine che mi leverà tutto.
“Hai dei figli?”
“Sì, uno. Si chiama Lorenzo. Ha due anni” – ti rendi conto che stai raccontando i fatti tuoi ad una che non sai nemmeno se si chiama Betty oppure no?
“Ti chiami Betty?” – le chiedo – “Mi sono accorto di non avertelo chiesto l’altra volta”.
Sono un mostro, è ufficiale. Lei si mette a ridere. Non sembra arrabbiata.
“NO! Per carità! Betty è il nome della ragazza che ho sostituito per maternità” – “Mi chiamo Elena. “
Ecco. Lo sapevo. Dovrò rifare tutti i miei filmini mentali con il nome giusto.
“Preferivo Betty, comunque.” Dico per sdrammatizzare.
Anche se poi tanto drammatico non è. Si tratta solo di un’altra delle tante nevrosi della società contemporanea. Che cazzo di differenza fa sapere il nome di una che tanto non conosci DOPO che ci sei andato a letto? I cani e i gatti si chiedono forse il nome prima di accoppiarsi??
“Già, Betty rende l’idea” . La vedo alzarsi, così com’è. Non deve avere più di 30 anni.
La vedo infilarsi gli slip i jeans mettere il reggiseno in borsa e allacciarsi la camicia.
E’ bella. No, non è bella ma io la trovo bella.
Prima di salutarci, davanti alla fermata del metrò che Elena deve prendere penso di dirle che non è il caso di vedersi ancora.
Mi sento uno stronzo.
Come si fa a dire ad una che ti sei appena portato a letto che è stata solo una botta e via quindi niente bacini e bacetti e quando ci vediamo?
“Quando ci vediamo?” – mi sento dire senza guardarla
“La prossima volta” – mi risponde Elena sorridendo mentre chiude lo sportello.
Poi s’imbuca giù, nella gola della linea Uno.
Quella sera a cena Cristina mi dice che sono silenzioso, un po’ assente, un po’ stronzo aggiungerei io.
Ma forse mi sento così perché mi hanno insegnato che dopo una “cattiva” azione mi devo sentire male.
Dopo aver tradito qualcuno DEVI necessariamente pagare il tuo tributo di sofferenza psicologica alla Società e a Dio.
Questo pensiero mi sfiora stasera, mi ha sfiorato in Novembre all’aeroporto di Parigi mentre aspettavo il volo per Linate che mi avrebbe riportato a casa, da Cristina e Lorenzo mentre Elena guardava di là, seduta accanto a me.
Nei miei viaggi di lavoro finti e in quelli veri non ho mai pensato di fare del male.
Mi sono strafogato di cono al cioccolato e panna per un po’, senza colpa e con qualcosa che somigliava tanto al sentimento.
Dico somigliava perché ancora adesso non lo so, cos’era quella cosa lì che sentivo per lei, Elena e per loro, Cristina e Lorenzo.
Una, due, tre, cento balle intorno a me. Una per me, le altre per te diceva una sorta di cantilena dei tempi in cui andavo a scuola.
Un passo di lato
Poi un pomeriggio rientro da Linate, un po’ in anticipo rispetto al previsto.
Tra un mese è Natale.
Ho ricevuto una mail di Cristina mentre ero a Parigi in cui sorridente mi racconta le richieste di Lorenzo a Babbo Natale.
Entro in cucina e inizio a scartabellare tra le varie buste che ho trovato nella casella della Posta. Mi chiedo per quale motivo dovrei adottare un Canguro Nano in via d’estinzione?? Mentre penso stupidamente assorto se sia davvero un buon investimento sommergere il cittadino di lettere pubblicitarie mi accorgo che sul mio estratto conto compaiono svariati pagamenti con carta al Motel Il Parco.
Mi guardo intorno inorridito. Che cazzo combinano questi idioti?!
Inizio a pensare a quando può essere arrivato l’estratto conto precedente, in effetti non mi sembrava di averlo visto.
Sono fottuto. Lei lo sa, lo sa.
Una stretta mi ha afferrato lo stomaco, Cristina stasera non tornerà e nemmeno Lorenzo. Se ne sono andati.
Ripenso alla mail di ieri sera. Quella mail sorridente e distesa.
Non può averlo scoperto.
Abbasso gli occhi per la seconda volta sull’estratto conto che tengo mezzo appallottolato nella mano destra.
Guardo i movimenti: 22/10/07 70 € Motel Il Parco, 23/10/07 70 € Motel Il Parco, 24/10/07 Motel Il Parco. …
Il 24 Ottobre ero a Parigi non a Milano. Guardo il nome sull’estratto conto .
Certo.
Quando la stanza smette di girare nel suo tango ridicolo penso alla filastrocca stupida delle elementari…Una, due, tre, cento balle intorno a me. Una per me, le altre per te. Sto ridendo. Sto ridendo. Sto ridendo.
Anche oggi, ripensando a quel momento stringo le mani nelle tasche, mi guardo dentro, mi guardo indietro, mi guardo di lato e giro attorno. Sorridendo.
SEZIONE VOLUMI
1° classificato: ALBERTO PELLAI di Somma Lombardo (Va) con “Stella come te”, “Lettera di Natale”, “Un asino per amico”, “Natale a ferragosto”
Pizzamento d’onore: VIVIANA FLABI di Bologna, con “Maxi il bassotto”
Menzione speciale: FRANCO ANSELMI di Vittorio Veneto (Tv) per le illustrazioni del volume di MARINO MURATORE di Genova, con “Il gato Peo e i cani verdi”